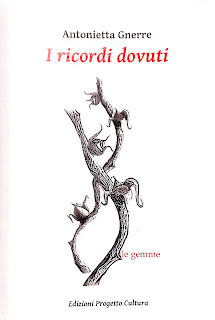STATO DELL’ESSERE IN PUBBLICO E PRIVATO DI DONNE
CHE RACCONTANO DI DONNE
 |
| Giuseppe Vetromile |
La mitologia greca classica abbonda di eroine meravigliose e di sulfuree, inquietanti anti-eroine (basti Medea per tutte): dalla coraggiosa e sensibile Antigone ad Alcesti, sposa che cede la vita in favore della reviviscenza del marito Admeto, laddove neanche gli anziani genitori di lui accettano di rinunciare agli anni che restano loro per salvarlo; dalla straziata vedova di Ettore, Andromaca, che si vede strappare il figlioletto Astianatte, affinché il dominatore acheo lo precipiti dalle rupi per impedirgli, crescendo, di vendicare il padre e la famiglia decimata (Neottolemo, figlio di Achille, lo ucciderà, gettandolo giú da una delle torri di Troia presso la porta Scea) ad Ecuba, annosa ma temprata regina di Ilio, che, in un celeberrimo monologo di Euripide, smonta con infallibile eloquio le pretestuose giustificazioni della maliarda Elena e consiglia al tronfio e manipolabile Menelao di non tradurla in patria sulla stessa nave, col rischio di essere ancora sedotto e gabbato dai fascini dell’insidiosa fedifraga. E come dimenticare Penelope, la fedelissima, la paziente, la previdente, l’icona maxima della compagna che confida nell’impossibile ritorno fino all’estremo, riuscendo a tenere a bada per lunghi, interminabili anni, la masnada dei ruvidi e avidi pretendenti?
Siamo titubanti nell’assegnare al nome di Ifigenia l’apposizione “eroina”, che il titolo della silloge suggerisce con marker invisibile e che le autrici invitate a partecipare con personali scritture in versi sul tema della donna combattiva, idealista, disposta ad avviarsi e a subire (allegorica) immolazione calamitosa, senza minimamente scomporsi hanno accettato (magari con qualche riserva, magari svicolando lungo i cunicoli di altri miti e altre protagoniste, come vedremo, o tout-court evitando ogni riferimento classico). Ifigenia è nota non per quel che fa, (non sfida né il fato né l’autorità terrena, come Antigone, che, opponendo a Creonte le ragioni del cuore e l’obbedienza alla prescrizioni divine, commette hybris, ingranaggio inesorabile) ma per quel che il suo destino scatena.
Figlia di Agamennone e di Clitemnestra (sorella di Elena, entrambe nate dall’uovo di Leda, fecondata da Zeus), fu indicata dall’indovino Calcante come vittima per placare la suscettibile Artemide, irata contro il re che vantava maggiore perizia di lei nelle pratiche dell’arco; con il ricorso all’ingannevole prospettiva delle nozze con Achille, la fanciulla venne attirata al sacrificio; ma la stessa Artemide, all’ultimo momento, la trasse in salvo, sostituendola sull’ara con una cerbiatta; condusse la risparmiata vittima tra i Tauri, ove sarebbe divenuta sacerdotessa addetta alla rituale soppressione degli stranieri transfughi o semplicemente indesiderati.
Una leggenda parallela vuole, invece, che i capricciosi dei esigano dai greci un sacrificio umano propiziatorio, altrimenti lasceranno i mari in bonaccia e flosce le vele della potente flotta. Ifigenia, neonata o comunque infante, prescelta come crudele prezzo da pagare per l’affrancante, sospirato soffio dei venti, è sottratta alla disperata e (vanamente) supplichevole Clitemnestra, che per questo atto odierà con implacabile crescendo il marito Agamennone, architettando una cruenta vendetta al suo ritorno in Patria dopo la subdola presa di Troia, rasa al suolo in una notte, grazie al tranello del ligneo cavallo dal capace ventre cavo.
Anche in questa versione, gli dei, notoriamente inclini a mutare decisione, si impietosiscono e la trasformano nella dea Ecate, mentre la disumanità dei mortali sarà punita con una serie di sanguinose conseguenze. In ogni caso, neonata o ragazza, Ifigenía si salva, o ottiene una compensazione.
In sé, Ifigenia, ignara o semi-inconsapevole, è travolta da decisioni stabilite per lei.
Sia come sia, il personaggio ha stimolato fior d’autori: Jean Racine (1674), P.J. Martello (1709), Guimond de la Touche, Ippolito Pindemonte, Goethe. E cosí i melodrammi di Scarlatti, di Jommelli, di Piccinni; mentre per la pittura incanta l’affresco del Tiepolo a villa Valmarana in Vicenza.
Il titolo e il tema dell’antologia del volume curato dall’inossidabile polivalenza di Giuseppe Vetromile per i tipi di Scuderi un anno fa suggeriscono la chiamata testimoniale di autrici che immaginano, descrivono, raccontano la nobiltà del femminino contro gli abusi, lo sciovinismo, l’iniqua ragion di stato. Molte poetesse nel passato e nel nostro immediato hanno subito persecuzioni, intimidazioni, concussioni, detenzione, perdita degli elementari diritti, torture, stupri, ritorsioni trasversali. Cosa che per fortuna è stata ed è risparmiata (che noi si sappia, dalle note biografiche in calce al volumetto) a Lucianna Argentino, Victoria Artamonova, Gaetana Aufiero, Floriana Coppola, Ulrike Draesner, Federica Giordano, Anila Hanxhari, Giovanna Iorio, Amalia Leo, Ketti Martino, Vera Mocella, Regina Célia Pereira da Silva, Monika Rinck, Anna Tumanova, Vanina Zaccaria. E a Rita Pacilio.
Di fronte a poetesse che hanno vissuto sulla pelle umiliazioni, angosce, sevizie fisiche e psicologiche in nome della libertà, e della verità, in Paesi che coartano, stroncando ogni pur minimo anelito in contrapposizione al diktàt governativo (nel nostro beneamato Stivale spessissimo in seno alla famiglia, ad opera di scellerati consorti o congiunti), e che purtroppo sapevano quel che descrivevano, le nostre imperterrite autrici “ifigeniadi” denunciano per sentito dire, cercano, buon dio, anche di immedesimarsi per quel che possono suggerire loro empatia e talento. ‘Testimoniano’ a seconda dei gradi della propria ars poetica.
Nel complesso, iniziativa e libro risultano accattivanti, e Vetromile ha intúito e mestiere; ovunque mette mano, il risultato è garantito. Complice qui la splendida tavola evocativa di Eliana Petrizzi, scrittrice, fotografa, designer e blogger, selezionata nel 2011 da Vittorio Sgarbi per la 54^ Biennale di Venezia, Padiglione Campania.
A noi non piace il biancore (patinato!) e la qualità della carta interna; la stampa è in digitale (insistiamo); mancano del resto le relative informazioni in seno al colophon, il quale ospita insolitamente un brano di Lucrezio in latino. L’inserimento di versi (siano del curatore del libro, del/degli autori o di poeti celebri) è una raffinatezza che va inserita a margine, nel colophon, dopo i dati tipografici). Utile, al contrario, l’apporto biografico sulle protagoniste della collettanea, corredato di commento critico succinto e compendioso, frutto delle solide competenze del demiurgo di Sant’Anastasia.
Lucianna Argentino, Floriana Coppola, Federica Giordano, Giovanna Iorio, Ketti Martino e Vanina Zaccaria sono, a nostro legittimo avviso, autrici di punta che fanno della parola/gesto mentale pessoano il flusso mirabile dell’ecceità poietica stessa; è, qui, la parola ad incarnarsi, non l’argomento a farsi parola, pur turgido che appaia il suo dettato. Ognuna lavora a favore di una fondazione poetriante di cifra, che si differenzi, che non cloni (tutto sommato anche inconsapevolmente) i miti, o peggio ancora, selli il destriero della prevedibilità, dello scontato, del luogo comune. Abitano, almeno queste autrici, nuove fondanti appartenenze, srotolano un filo muscolare, diremmo fisiologico quanto filologico, penetrano i contrasti, non demonizzano le contraddizioni, reggono il ritmo con una cadenza misurata e coerente; non disdegnano chiazze d’ombra tra i cui piovaschi fogliacei miscelare la verità e quel pizzico di irresistibile finzione che è patrimonio del creativo, da Lorenzo il Magnifico a Olimpo da Sassoferrato, da Gozzano a D’Annunzio, a Giambattista Marino, da Clemente Rebora a Umberto Saba, da Gaspara Stampa a Elsa Morante, alla Merini, a Vivian Lamarque.
Piace il nitore stringato, eminentemente tonale di Giovanna Iorio che ha la cura netta, quasi ossequiosa dell’essenziale; produce un verso percussivo, esatto, aerodinamico, che nei ‘feuillets’ de ‘Le dodici pietre’ fende il sangue e scioglie riserve all’inserzione della voce intima, quella che si ascolta riprodotta dall’occhio intelligente di chi legge a voce allenata. Si limita a incrociare Níobe (convertita in pietra dal dolore dopo la strage dei figli ad opera di Apollo e Artemide, indi tradotta dagli dei sul monte Sipilo nell’odierna Turchia) e lo fa in un radente passaggio, segnando i tempi della leggerezza nello struggimento; si mimetizza per un attimo bluastro in una peruviana masticatrice/conciatrice di Tumbes; per il resto non lascia dileguare l’appartenenza a un sé che si rastrema (senza occultare) con tutta la grazia della trasparenza di partizione strofica e di estensione emotiva. Non carica i simboli, non sbava in nessuna persistenza, è artiera di una pietra nobile, scabra e duttile quasi per metaplasica derivazione.
Lucianna Argentino interpella il desiderio, l’errore e il peccato con la suasione suggestiva di un sogno allo specchio (rimandiamo il lettore al saggio/romanzo del pensiero umano “La corazza ricamata”, di Roberto Peregalli, Bompiani, 2008; nella fattispecie al cap.2 ‘Il rischio della conoscenza’), che la proietta in controcanto nel ratto di una Proserpina custode di languori, consensualità e impulso ribelle ricacciato giú per un ubiquo raddoppiamento di istante e di distanza, di prossimità e di fuga, entrambe tentazioni che confondono ed eccitano la mente-cuore, in perenne stato d’alterna sublimità e terragna cocenza sessuata. Il suo stile è una confessione a voce spiegata, mai tremula: anzi determinata, non oltrepassante la soglia di una esplicitazione spellante e sfacciata, vira inaspettatamente nell’accostamento a Maria di Luca, permutata in una figuretta isolata, parte dell’immagine fiabesca di un Capuana, di un Basile, ricca d’una lanterna e di un foglio nel quale riversarsi in tutt’uno.
Ifigenia, oggetto di eventi piú grandi, e tragici precursori di effetti ancor piú devastanti, Ifigenia che non sa e non può scegliere, in realtà non muore, viene trasfigurata e gravata di inedite responsabilità, divenga essa Ecate o designata sacerdotessa mortifera per capriccio e per pietà di Artemide/Diana. Con originalità e genio complessivo, Federica Giordano disegna e proietta un gesto scaramantico che in ogni epoca si irràdi, in ogni tempo si sprigioni; tempo che per lei s’intuisce essere un’unica retta ove scarso senso hanno le distinzioni di passato/momento attuale/avvenire. Luminosi e numinosi gli accostamenti lessicali, cosí le invidiabili intuizioni, mentre scivola avanti/indietro, contemporaneamente nella bella (e impressionante) atemporalità la voce anch’essa logicamente atavica e profetica di sé, in prossimità e lontananza che solo la poliedrica plasmabilità mitica (greca o egizia che sia) può formare e aggregare. E se è la poetessa napoletana di “Nomadismi” a suggerire involontariamente la nominazione alquanto malintesa del titolo della raccolta, giacché la Giordano non si sogna di elevare Ifigenia a icona del sacrificio o a pasionaria antroposociale politicizzata (basta e avanza Antigone), il suo dire scava nell’eterno ritorno derivato dall’illusorio ‘andare’. Dal visibile alla decifrazione dell’invisibile. Eccellente, illuminante, mistico-straniante eppure straordinariamente etico-spirituale il morceau ‘Cicli’, dove fine e inizio (naturalmente) collimano.
Ketti Martino mantiene alto (e piú che mai alto) il registro prendendo misure precauzionali di distanza dall’ovvietà in cui una scrittrice del suo calibro non può scivolare neanche per un frammento di distrazione, o per diabolico sberleffo del caso; non ha bisogno di rileggere la cronaca (morbosa) alla moda, di calcare il tallone per viottoli praticati fino alla nausea, alla guida di un SUV o con la testa cotonanda in un casco dal parrucchiere, mentre ci si gingilla a rivendicare le beau geste dell’engagement sartriano, scomodando il succo di discorsi storico-teorici di storici maîtres à penser, magari ricombinando espressioni còlte dagli editoriali di Travaglio o dal compianto palinsesto di ‘NoiDonne’ (Cooperativa Libera Stampa). Diciamo basta alla retorica su Gaza, su Lampedusa, sul Nepal, frignando con un occhio solo sui bimbi arsi dal napalm! Confrontiamoci, piuttosto, con l’arguto –e agghiacciante– testo di ‘The Bombs’ di Martha Collins, tutto in strofe di un solo verso, compreso nella raccolta “Sheer”!(Tanto per verificare il superamento del banale e dell’enfatico artificiosamente riprodotto ad effetto, prendendo atto, in umile esercizio, che ben altre sono le vette dell’originalità…) ‘In fieri’ è un petit chef-d’œuvre dove ‘l’imperfezione’ sublima paradossalmente ogni mancanza, ogni addio, ogni esilio, ogni ferrea o equivoca/equivocata ‘legge’. Eppure a nostro (opinabile) giudizio la Martino avrebbe potuto concludere alla seconda strofa della sequenza II, espunta con l’abolizione dei due versi terminali, inglobabili invece all’inizio della parte III: “La tenerezza ha angoli nascosti,/ non li vedi?” E à ce propos, i finali due versi de “L’Io scrivente” risultano una possente dichiarazione di poetica. Val la pena di citarli: “Alla luna lascio le mie carte, le sospensioni e ogni confine./ Inoltro bolle di sapone senza attesa di risposta.”
Vanina Zaccaria si tuffa e ci rituffa nelle atmosfere classiche (da buona attrice non può non amare la Triade insostituibilmente formativa Eschilo/Sofocle/Euripide) di una Atene immortalata come alfa e omega, metafora
della bellezza, del pensiero, dell’arte della parola, di prodigiose armonie; prosegue cantando del Peloponneso rovente di spade, scudi corruschi e roghi di navi, quindi in trasvolata lambisce il Dodecàneso (o Dodecanèso, le 12 isole dell’Egeo che dal 1912 al 1947, incluse Rodi, Lisso e Coo, furono sotto il dominio italiano), indica Lindos, Ialissos, Kamiros, ne saggia gli odori, i colori, tentata dai misteri che ogni scrigno/adyton/non luoghità riserva al curioso pellegrino, per approdare ad Argo, dove “ci siamo venduti al vento un corpo di ragazza/ne abbiamo baciato le dita con intima vergogna/ne abbiamo scorto i seni bianchi/dibattersi alla corda/come blande meduse/trascinate dalla chiglia”. Il metro è gentile, fende le stanze della mente, ci invita a esporci, ad accedere direttamente ai cataloghi del tempo, ripesca il mito, ma lo fa con grazia, con cautela, consapevole che la crudeltà imbratta l’idillio, appanna l’ideale, interrompe l’incanto e i flauti, apparecchia la catastrofe, l’angoscia epocale.
Per ultima, e non ultima delle italiane a nostro avviso e gusto significative in questa antologia, anzi collocata in cauda come per assaporare con ‘trepidante calma’, ossimoricamente, il boccone piú ghiotto, Floriana Coppola ci regala l’Ineffabile Poetico con il poemetto “Non sono che la madre”. Qui il pathos ascende allo zenit e lo fa con una pluralità di toni, in un recitativo teatrale che richiama “Toutes voix confondues” del menestrello della ‘banlieue’ parigina, amico di Aragon e di Frénaud, Gérard Noiret, ma anche conduce alla summenzionata nordamericana Martha Collins con le diverse storie, le ‘Several Things’, le diverse cose che compongono un puzzle eloquente e terribile, dove una voce s’insinua in un’altra voce, che poi è la stessa, il disgiunto diventa connessione splendida e meditativa, il punto focale assume un fascino disturbante che non offende ma tiene desti, allerta, in attesa di rivelazioni, mentre intervalli significativi acquistano funzioni e frequenze uditive/visive. La metafora materica (corallo, giada, cartapesta, piombo, legno aromatico, sasso, frutto, foresta, rovo, carne incatenata alle inferriate) non è tanto versatilità trasformista ab ovo quanto polifonia enunciativa di verità (o quantomeno di inveramento): ‘terra, sogno, punto, istante racchiuso da un cerchio’ (per rifarci a Francisco de Quevedo); la madre spende tutto di sé senza risparmio, per eletta condizione, istinto, DNA. E lo fa in sordina, senza reboanti esplosioni di guerriera temprata dalle bufere, senza percuotersi il petto; senza rendiconto di sacrifizi; anzi, scarne definisce carezze e parole che offre ogni giorno, riservando a se stessa immagini di ali alle caviglie e proiezioni di chimere, miraggi, mentre restituisce crediti, impasta il pane del mattino, contempla la traccia dormiente dei corpi piccini e belli nella culla vuota. E si confessa ombra domestica ma anche ardore, che s’attarda nei cortili a sgranare buffole di bugie (e non menzogne) in una sospensione d’animo reificante. Sembra sorgere e delinearsi in un lampo d’ombra l’aria di Quasimodo, che alla Aleramo si rivolgeva a cuor gonfio: “Ti penso serena, regale. E le ali, le ali, mio amore?”
Pregevole, dunque, il libretto, che promuove anche la Scuderi; libretto che se si fosse arricchito di un bouquet nostrano e partenopeo/casertano di altrettante tedofore, portatrici di armoniosa idealità e di combustiva figurazione espressiva e immaginativa (stiamo parlando di Mariastella Eisenberg, Monia Gaita, Antonietta Gnerre, Claudia Iandolo, Agostina Spagnuolo, Carla De Falco) avrebbe magnificato nella molteplicità degli scatti e dei vetri zigrinati (per parafrasare Magrelli) di tic, umori, illuminazioni e nevrosi un panorama di inconsueta perfezione d’incontro, e musicale e semantica, capace di reggere l’impossibile confronto con quelli che noi unanimemente nominiamo ‘Spiriti Magni’ ( Saffo, Catullo, Ovidio, Petrarca, Dante, Ariosto, Foscolo, Leopardi, Rimbaud, Lorca, Achmatova, Cvetaeva, Neruda, Prévert, Luzi…). E scusate se è poco.
Non ci soffermiamo sulle straniere: non conoscendo il russo, non sufficientemente il tedesco e il portoghese, ci dobbiamo rifare alle traduzioni, che sono immancabilmente dei ‘tradimenti’, dei ‘travisamenti’ rispetto all’originale, nonostante la preparazione del traduttore, che spesso è egli stesso poeta (qui Federica Giordano nel caso di Monika Rinck). L’altissima incidenza di inevitabile ‘riscrittura’ e di proposizione di poesie ‘diverse’ (e sinceramente eviscerate, piallate) ha persino toccato, illo tempore, Pasquale Martiniello, quando ha traslato in lingua le sue formidabili produzioni in koinè (‘No munno spierso’); l’onestà di Maria Grazia Marzot, pregevolissima traduttrice, le ha impedito di trasporre alcuni sonetti di Martha Collins, per esempio, zeppi di ‘double entendre’ dal garbuglioso scioglimento e di giochi di parole impossibili da rendere in una lingua differente senza che il gusto e il senso andassero dispersi, vanificati. Costretti a basarci sulle versioni in italiano, assegniamo il nostro apprezzamento a Ulrike Draesner (‘What is poetry?’), a Regina Célia Pereira da Silva ed a Monika Rinck per eclettismo, Witz mordace, graffiante disincanto weberiano, per indizio di irripetibilità. Deludente Victoria Artamonova, il cui componimento (pretenzioso nel titolo, ma arente e scialbo nei contenuti) ‘Lettera a Petrarca dalla Russia’ risulta un’occasione mancata.
ARMANDO SAVERIANO
AA.VV. IFIGENIA SIAMO NOI – A CURA DI G. VETROMILE – SCUDERI ED. 2014 – PP.96 € 12.50
 |
| Ifigenia vista dal pittore Tiepolo |
 |
| Federica Giordano |
 |
| Floriana Coppola |
 |
| Giovanna Iorio |
 |
| Ketti Martino |
 |
| Lucianna Argentino |
 |
| Vanina Zaccaria |